La
Comedìa:
tra volgare illustre e dialetto
tra volgare illustre e dialetto
di
Luigi Murolo

In
occasione della prima edizione della giornata dedicata alle celebrazioni per il
settecentesimo anniversario della morte di Dante (1321) – il cosiddetto
«Dantedì» –, l’Istituto per la Storia di Vasto non si sottrae
all’obbligo culturale e morale di partecipare, seppur sommessamente, alle
onoranze corali per questo genio universale.
Dal
chiuso di una stanza – per l’«inferno» della crisi epidemica, e non per quanto
si era progettato in forma pubblica –, avviamo la lettura dei primi cinque
canti dell’Inferno, gli unici tradotti in dialetto da Giuseppe Perrozzi
(1899-1973). A conferma del fatto che, anche se non esplicitamente dichiarato,
il poeta vastese voleva dimostrare che, non solo il volgare doveva
essere illustre (nell’accezione alighieriana), ma lo stesso dialetto
rientrava in tale orizzonte culturale.
La
traduzione delle grandi opere offre la misura della letterarietà della lingua
che riceve il testo originale. Ad esempio, la restituzione concettuale in
dialetto dell’amor cortese che dai Siciliani, agli Stilnovisti giunge
fino a Dante costituisce una verifica fondamentale per comprendere la
versatilità «culta» della lénga huaštaréulǝ. «Amor, ch’a nullo
amato amar perdona» per il traduttore si trasmuta in «L’amore tocche
l’anime cchiù fine» (ricordo che Perrozzi, nel caso della comedìa non
usa il dialetto vastese parlato negli anni quaranta/cinquanta del secolo
scorso, ma la forma lenita della koiné abruzzese). Qui c’è addirittura
il recupero teorico e terminologico della fin amor occitanica (che non
implica il possesso, ma il desiderio che nobilita l’animo). Da non
dimenticare la stessa ricerca del lessico: una Cleopatràs che da «lussuriosa»
diventa «cervellina»; vale a dire, ingegnosa nella pratica del piacere. Oppure,
dove «A vizio di lussuria fu sì rotta […]» si trasforma in «Ere piene di
vizie e di vulije … / Cchiù di chistì, nisciùne ha
fatte pegge». Dove vulije sembra riecheggiare il «ben volria»
occitanico che, nel suo valore condizionale, la trobairitz Beatriz de Dia (sec.
XII) usa nella cansò dal titolo «A chantar m’er de so qu’en no volria».
Mi
limito solo a queste brevi considerazioni per suggerire l’interesse che riveste
la singolarissima versione perrozziana della Comedìa. Ma anche per
sottolineare un altro dato: la relazione che si può evincere dal rapporto
dialetto letterario/volgare illustre.
E
non è poca cosa per il Dantedì vissuto in solitudine tra le pareti
domestiche, in attesa che l’esterno dei nostri giorni da Inferno si trasformi
quanto meno in Purgatorio. In
effetti,
Il Paradiso può attendere (Heaven Can Wait) se vogliamo attenerci
al titolo del film che Warren Beatty ha realizzato nel 1978.
Video n. 1 - Introduzione
Video n. 2 - Lettura in dialetto vastese
INFERNO
Canto V
I LUSSURIOSI
(Testo in dialetto abruzzese)
1
Da chilu prime cerchie so’ calate
Abbasse a lu seconde ch’è cchiù strette
Ma lu dulore a ecche è radduppiate.
2
Minosse, gne nu cane, scì mmaldette,
Rufe e arrajate, fa vidé li zanne;
S’attircine
la code nghi ddispette
3
Tanda vodde, seconda la cundanne.
Annanz’ a esse, l’anima dannate
Sa d’hanna presentà da ogni vvanne
4
E canda cchiù è ggrosse lu peccate,
cchiù abbasse vé l’alme sprufunnate.
E cchiù abbasse vé l’alme sprufunnate.
5
Sti disgraziate stanne arreunite
E appene condannate e mmaleditte,
Vanne a ffinì a ddò jé stabbilite.
6
Minosse, viste a mmé che stave zitte,
Lassanne nu mumente la fatije:
̶ «
A ecche si vinute? Fa lu dritte!
7
Arripe l’ucchie e vvì che strada pije!
Stu poste è llarghe, ma ‘n da dà fidà
Nemmene de ‘ssa bbella cumpagnije! » ̶
8
Lu Mastre risintite: ̶ « Nen strillà!
Lassele ì’ addò vò lu distine
Stabbilite da Chi po’ cummannà! » ̶
9
Mo cumenze a ssentirle da vicine
Li guaje e ttanta piante di dilure
Sempre cchiù fforte, mentre m’avvicine.
10 Nu
stavame a nu poste tutte scure
E ssembrave a ssentì gna fa lu mare
Cand’è in tempeste, che tte fa paure.
11 Da
sta tempeste nen ci sta ripare,
Pecché li spirite, a fforze, so vvussate
Da nu gran vente e ffanne na fiumare.
12 E
ggiranne accuscì, l’alma dannate
Se danne fra di isse cchiù ccimente,
Sprezzanne la Virtù che Ddì ci ha date.
13 Hajje
capite allore a cchi tturmente
E’ state condannate chi ha vulute
Nghi la carne gudè ore e mumente
14 E
gne d’inverne volene sbattute
Da forte vente, tante e tanta cille,
Cuscì, pur’isse, st’anime perdute
15 Vanne sbattenne tale e quale a
cchiille,
Senza sperà nu ccone da ripose,
Hanna scuntà sta pene fra li strille.
16 E gne le grù, nghi voce lamentose,
Vanne strillanne canda stanne in vole,
M’è ssimbrate a vvidé la stessa cose.
17 Hajje ditte a lu Mastre sti parole:
̶ « Chi è sta ggente tante castigate
Da st’aria
nere, addò ‘n ci sta mà sole? » ̶
18 ̶ « La prime che vva ‘nnanze a sta
sfilate
E’ state ‘mperatrice e le famije
Di tanta rrazze ha tutte assoggettate.
19 Ere piene di vizie e di vulije…
Cchiù di chistì, nisciune ha fatte pegge,
Che ppe’ ggiustificà li purcarije,
20 La purcarije è divindate legge.
Si chiame Simiramie, mojje a Nnine,
Mò lu sultane chi la terra regge;
21 L’addre è Ddidone ch’ere na riggine
S’è ‘ccise picché l’hanne abbandonate.
Po’ ci sta Cliupàtre, cirvilline;
22 Elene che la guerre ha scatenate;
Doppe ve’ Achille, chi lu gran guerriere
Che ppè l’amore è state trucidatre.
23 Po’ Paride e Tristane cavaliere
E doppe, tanta ggente … Pe’ ffurtune
Lu Mastre a mmé, pe’ ffarme nu piacere,
24 Lu nome me diceve de ciascune.
Doppe avè viste tutte ste persone,
Hajj’ avute pietà pe’ quacchedune.
25 Diche a lu Mastre: ̶
« Sinte, si vva bbone,
Jvulesse
parlà nghi chili du’
Che stanne
accuscì strette nghi passione. » ̶
26 Lu Mastre m’ha risposte: ̶ « Si li vu’
Canda
lu vente a ecche le strascine
Si ttu li chieme, venne addò ste tu. » ̶
27 Di fatte chila coppie s’avvicine.
Hajje ditte: ̶ « Si nen v’è pruibbite,
Venitece a pparlà cchiù da vicine. » ̶
28 E gne ddu picciuncille ‘mpaurite
Vanne a lu nide nghi li scinnilelle
Tese e ddititte tutte e ddù’ arriunite,
29 Cuscì
da sta fiumara di ribbelle,
So’ sciute ‘ncontre a nnu sti scannusciute
Ch’avevene risposte a cchil’ appelle.
30 ̶ « Tu, ommene ggentile, sì vvinute
A
vviderce a ssuffrì, ma da sti vene
Si tu
sapisse, canda sanghe è asciute!
31 Ddije
ch’è granne, nen ce vo’ cchiù bbene …
Ne je puteme cchiù pregà la pace
Pe’ tté che ttì pietà de chiste pene.
32 Addummannate
quelle che vvi piace,
Mentre lu vente atturne già si pose,
Pure quelle che ccerte ce dispiace.
33 La
terre addò so’ nnate, è bbasse e ariose
Addò lu Po ascegne a la marine
E ttrove finalmente lu ripose.
34 L’amore
tocche l’anime cchiù ffine:
Chi mi stà a ffianche te stu bbelle done
E cchi l’ha ccise, è state n’assassine.
35 L’amore
cande è fforte nen perdone:
J, de custù, so’ state ‘nnammurate,
Ca pure mò, ancore m’abbandone.
36 L’amore
a nnù la morte ci ha purtate,
Ma certe a lu spruffone va a ffinì
Chi a ttutte e ddù la vite ci ha levate. » ̶
37 Canda
ha finite de parlà accuscì,
Triste la cocce hajje acciaccate ‘n pette.
Lu Mastre m’ha guardate: ̶ «Mbeh,
chi dì?» ̶
38 J’hajj’
arisposte: ̶ « Brutta sorte aspette
A chi ha sentite veramente amore,
Che le fa sta fra ggente maledette! » ̶
39 Hajje
parlate e mi vatté lu core:
̶ «
Francesche – hajje ditte – tutte chisse pene
A mme me fanne piagne de dulore;
40 Tu
m’ha’ dice, come po' nu bbene
Trasfurmarse accuscì, nghi na passione
Che v’abbrusciave sanghe ne le vene?» -
41 Esse
ha risposte: - «N ci sta na persone
Che ccand’è ddivintate puverelle,
Nen se po' mà scurdà lu tempe bbone.
42 Ma
se le vu sapé gna è nnate quelle
Che a nnù ci ha date ggioje e po' la morte,
Mi sinte a ppiagne e ssintela favelle.
43 Leggiavame
nu libbre che riporte
L’amore d’une, ch’ere Lancillotte;
Stavame sole e ‘n ceravam’ accorte
44 Ca
chilu scritte, gne nu galiotte,
Ce stave a suggerì gna è l’amore
Però na cosa sole a nnu, de bbotte
45 Ci
ha fatte cagnà ‘n bacce lu culore:
Ce stave scritte che la vocca a rrise
Tante è belle basciarle e stu signore,
46 Che
d’allore da me ‘n s’é ma’ divise,
M’ha basciate tremante, nghi na freve
E dope
poche seme state accise.» -
47 Mentre
Francesche queste me diceve,
L’addre piagneve. J ere tutte smorte
L’addre piagneve. J ere tutte smorte
Tant’ere la pietà che me muveve,
48 Ca
so’ ccascate ‘n terre gne nu morte
Canto
V
(Testo originale)
Così
discesi del cerchio primaio
giù
nel secondo, che men loco cinghia,
e
tanto più dolor, che punge a guaio. 3
StavviMinòs
orribilmente, e ringhia:
essamina
le colpe ne l’intrata;
giudica
e manda secondo ch’avvinghia. 6
Dico
che quando l’anima mal nata
li
vien dinanzi, tutta si confessa;
e
quel conoscitor de le peccata 9
vede
qual loco d’inferno è da essa;
cignesi
con la coda tante volte
quantunque
gradi vuol che giù sia messa. 12
Sempre
dinanzi a lui ne stanno molte;
vanno
a vicenda ciascuna al giudizio;
dicono e odono, e poi son giù volte. 15
«O
tu che vieni al doloroso ospizio»,
disse
Minòs a me quando mi vide,
lasciando
l’atto di cotanto offizio, 18
«guarda
com’entri e di cui tu ti fide;
non
t’inganni l’ampiezza de l’intrare!».
E
’l duca mio a lui: «Perché pur gride? 21
Non impedir lo suo fatale andare:
vuolsi
così colà dove si puote
ciò
che si vuole, e più non dimandare». 24
Or incomincian le dolenti note
a
farmisi sentire; or son venuto
là
dove molto pianto mi percuote. 27
Io venni in loco d’ogne luce muto,
che
mugghia come fa mar per tempesta,
se
da contrari venti è combattuto. 30
La bufera infernal, che mai non resta,
mena
li spirti con la sua rapina;
voltando
e percotendo li molesta. 33
Quando giungon davanti a la ruina,
quivi
le strida, il compianto, il lamento;
bestemmian
quivi la virtù divina. 36
Intesi ch’a così fatto tormento
enno
dannati i peccator carnali,
che
la ragion sommettono al talento. 39
E come li stornei ne portan l’ali
nel
freddo tempo, a schiera larga e piena,
così
quel fiato li spiriti mali; 42
di qua, di là, di giù, di sù li mena;
nulla
speranza li conforta mai,
non
che di posa, ma di minor pena. 45
E come i gru van cantando lor lai,
faccendo
in aere di sé lunga riga,
così
vid’io venir, traendo guai, 48
ombre portate da la detta briga;
per
ch’i’ dissi: «Maestro, chi son quelle
genti
che l’aura nera sì gastiga?». 51
«La
prima di color di cui novelle
tu
vuo’ saper», mi disse quelli allotta,
«fu
imperadrice di molte favelle. 54
A vizio di lussuria fu sì rotta,
che
libito fé licito in sua legge,
per
tòrre il biasmo in che era condotta. 57
Ell’èSemiramìs,
di cui si legge
che
succedette a Nino e fu sua sposa:
tenne
la terra che ’l Soldan corregge. 60
L’altra è colei che s’ancise amorosa,
e
ruppe fede al cener di Sicheo;
poi
è Cleopatràs lussuriosa. 63
Elena vedi, per cui tanto reo
tempo
si volse, e vedi ’l grande Achille,
che
con amore al fine combatteo. 66
Vedi Parìs, Tristano»; e più di mille
ombre
mostrommi e nominommi a dito,
ch’amor
di nostra vita dipartille. 69
Poscia ch’io ebbi il mio dottore udito
nomar
le donne antiche e ’ cavalieri,
pietà
mi giunse, e fui quasi smarrito. 72
I’ cominciai: «Poeta, volontieri
parlerei
a quei due che ’nsieme vanno,
e
paion sì al vento esser leggeri». 75
Ed elli a me: «Vedrai quando saranno
più
presso a noi; e tu allor li priega
per
quello amor che i mena, ed ei verranno». 78
Sì tosto come il vento a noi li piega,
mossi
la voce: «O anime affannate,
venite
a noi parlar, s’altri nolniega!». 81
Quali colombe dal disio chiamate
con
l’ali alzate e ferme al dolce nido
vegnon
per l’aere dal voler portate; 84
cotali uscir de la schiera ov’è Dido,
a
noi venendo per l’aere maligno,
sì
forte fu l’affettuoso grido. 87
«O
animal grazioso e benigno
che
visitando vai per l’aere perso
noi
che tignemmo il mondo di sanguigno, 90
se fosse amico il re de l’universo,
noi
pregheremmo lui de la tua pace,
poi
c’hai pietà del nostro mal perverso. 93
Di quel che udire e che parlar vi piace,
noi
udiremo e parleremo a voi,
mentre
che ’l vento, come fa, ci tace. 96
Siede la terra dove nata fui
su
la marina dove ’l Po discende
per
aver pace co’ seguaci sui. 99
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende
prese
costui de la bella persona
che
mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende. 102
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi
prese del costui piacer sì forte,
che,
come vedi, ancor non m’abbandona. 105
Amor condusse noi ad una morte:
Caina
attende chi a vita ci spense».
Queste
parole da lor ci fuor porte. 108
Quand’io intesi quell’anime offense,
china’
il viso e tanto il tenni basso,
fin
che ’l poeta mi disse: «Che pense?». 111
Quando rispuosi, cominciai: «Oh lasso,
quanti
dolci pensier, quanto disio
menò
costoro al doloroso passo!». 114
Poi mi rivolsi a loro e parla’ io,
e
cominciai: «Francesca, i tuoi martìri
a lagrimar
mi fanno tristo e pio. 117
Ma dimmi: al tempo d’i dolci sospiri,
a
chee come concedette Amore
che
conosceste i dubbiosi disiri?». 120
E quella a me: «Nessun maggior dolore
che
ricordarsi del tempo felice
ne
la miseria; e ciò sa ’l tuo dottore. 123
Ma s’a conoscer la prima radice
del
nostro amor tu hai cotanto affetto,
dirò
come colui che piange e dice. 126
Noi leggiavamo un giorno per diletto
di
Lancialotto come amor lo strinse;
soli
eravamo e sanza alcun sospetto. 129
Per più fiate li occhi ci sospinse
quella
lettura, e scolorocci il viso;
ma
solo un punto fu quel che ci vinse. 132
Quando leggemmo il disiato riso
esser
basciato da cotanto amante,
questi,
che mai da me non fiadiviso, 135
la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto
fu ’l libro e chi lo scrisse:
quel
giorno più non vi leggemmo avante». 138
Mentre che l’uno spirto questo disse,
l’altro
piangea; sì che di pietade
io
venni men così com’io morisse.

Dante Gabriel Rossetti
Paolo and Francesca da Rimini

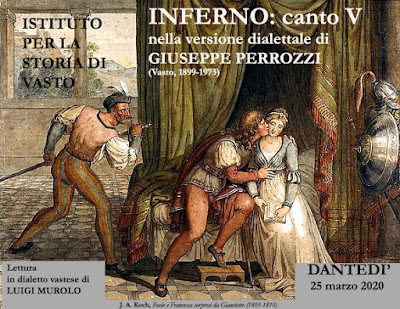
Nessun commento:
Posta un commento