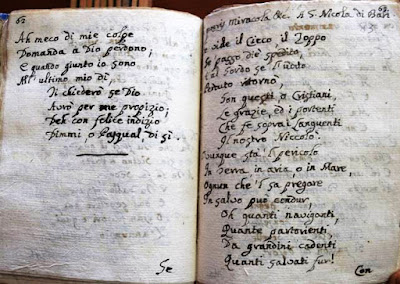PER UN’ANTROPOLOGIA STORICA DI UN CULTO LOCALE
di
Luigi Murolo
Ciò
che intendo affrontare in questa sede è il modo in cui nasce, agli inizi del
XVIII secolo, un culto come quello su pellegrinaggio e festa di S. Nicola di
Bari. Che poi costituisce un uscir-fuori collettivo dalle mura urbane estraneo
alla traditio locale, che viene pubblicamente riconosciuto dalla massima
auctoritas civile della città in ragione dell’adempimento di un voto per
grazia ricevuta. La cinta muraria non costituisce più un limite verso
l’esterno. Tutti possono varcare la soglia in exitu: ma alla sola
condizione che sia itinerarium fidei. L’approccio verso l’aperto non è
più solo autorizzazione per un singolo: ma diventa transito di una communitas.
È questa prospettiva religiosa del viaggio che ne garantisce la possibilità
terrena. Viaggiare da soli è periculosum maxime. In comitiva il singolo
è protetto. Questa marcia accidentata sulla terra (boschi, fiumi, rilievi ecc.)
discopre il sovrasenso che ne è il motore. Nella pratica antropologica del
viaggio collettivo, l’abitatore della città sperimenta l’oggetto che lo
determina. Quest’orizzonte culturale non fonda se stesso su una traditio.
È la sua ripetibilità a determinarne il funzionamento. Da questo punto di vista
si assiste a un mutamento di outillage religioso. Che non è solo
dottrina con ragioni in se stesa, ma prima di ogni altra cosa, prassi antropologica.
Inizio
dal luogo di culto, per il fatto che, seppur esistita all’interno del centro
antico di Vasto una chiesa intitolata a S. Nicola dei Guarlasi (poi a S.
Maria del monte Carmelo), essa non ha mai avuto relazione con gli abitatori
autoctoni. Fin dall’istituzione del consolato raguseo in città nel 1523, è
stata sede religiosa della ricca comunità mercantile transadriatica qui
allocata. Ora, se la festività del santo era patrimonio cultuale dei semplici
domiciliati – vale a dire degli stranieri dell’altra sponda–, non lo stesso si
può dire per i residenti (la figurazione bizantineggiante del Nicola di Cona
di mare [fig. 1] è in posizione laterale e sussidiaria rispetto alla
tipologia odeigitria della Theotokós vastese). In effetti,
l’elenco delle festività da celebrare riportato dagli Statuti comunali
di Vasto di metà Cinquecento (I, 2; il secondo capitolo
del primo libro dal titolo De festiuitatibus celebrandis), non
restituisce alcun riferimento al vescovo di Mira (in effetti, oltre alle
domeniche e alle feste in onore del Cristo e della Madonna, risulta documentata
la venerazione civile e religiosa solo per «Sancto Laurentio, Santo
Augustino (…) Santo Matheo, Sancto
Joannj, Sancto Marcho, Santo Angelo de Septenbro [S. Michele], Sancto Stefano,
Santo Honofrio, Sancto Rocho, Santo Sebastiano, Sancto Leonardo, Santo Thomasi
de Aquino, Santo Nicola da Tollentino»). Tra le ottantasei festività
religiose attestate nel documento, l’unica menzione per un Nicola è quella
relativa al santo agostiniano Nicola da Tolentino canonizzato nel 1446 e
venerato nella chiesa di S. Agostino (oggi S. Giuseppe) di cui esisteva una
cappella fino al 1890. Da ciò si evince che risulta posteriore alla metà del
XVI secolo il culto per il Nicola baresano se è vero che, stando alla
testimonianza dello storico Nicola Alfonso Viti (1600-1649), due cappelle
rurali intitolate al suo nome risultavano attive nel Vasto del 1644: S. Nicola
della Meta, S. Nicola di Torricella.
(Fig.
1: Michele Greco da Valona, Trittico di Cona di Mare (1505).
Particolare
di S. Nicola)
Dal
punto di vista cultuale, la menzione del pellegrinaggio vastese più antico fino
a oggi conosciuto al Santo di Bari si deve alla penna di Diego Maciano nel colportage
da lui compilato tra il 1700 e il 1729. Qui l’autore spiega le ragioni del
viaggio iniziato il 27 aprile 1714: la confraternita del Carmine si reca a Bari
per adempiere al voto sulla guarigione della marchesa del Vasto Ippolita
d’Avalos in quel periodo ancora impossibilitata perché convalescente (voto
definitivamente sciolto l’anno successivo con un sontuoso viaggio calessato,
non a piedi). La lista dei partecipanti all’iniziativa di ringraziamento,
redatta sempre dallo stesso Maciano il 26 aprile 1714 [fig. 2], veniva
annotata sul retro dell’anteporta di un cabreo recentemente scoperto da Paolo
Calvano:
(Fig.
2:
La lista dei partecipanti al pellegrinaggio del 1714)
Come
si può osservare, in assenza di una cultualità autoctona, il pellegrinaggio
“popolare” nasce come servizio religioso ai signori del luogo. La stessa
presenza di ben sei presbiteri (Diego Maciano, Francesco Gatta, Giuseppe
Cacciuni, Gio.Carlo Pettine, Giuseppe Impastari, Giacinto Oliuij) avrebbe contributo
alla diffusione cittadina della devozione. Al punto che lo stesso nipote di don
Giacinto Oliuij, Francesco Oliuij Leone (lo stesso autore dell’Inno alla
Sacra Spina in latino) avrebbe composto il testo con una versificazione di
facilissima memorizzazione (quartine di settenari piani con settenari tronchi e
un solo settenario sdrucciolo) di cui non è pervenuta la partitura musicale. Il
brano, rimasto inedito (trascritto a mano dallo storico ottocentesco Luigi
Marchesani [figg. 3, 4, 5] insieme con tutta la pia guida dei canti
laudatori in italiano del Leone, in due volumetti in-24°, dal titolo Parafrasi,
ed Inni sagri). Alle pp. 63-66 della seconda parte è contenuto l’Inno a S.
Nicola di Bari che riproduco:
(Fig.
3)
(Fig.
4)
(Fig.
5)
Il
testo manoscritto dell’Inno a S. Nicola di Bari
A
San Nicola di Bari
(trascrizione)
Se
vide il cieco, il zoppo
Se
‘l passo die’ spedito,
e
al sordo se l’udito perduto
Perduto
ritornò,
Son
questi, o Cristiani,
Le
grazie ed i portenti
Che
fe sopra i languenti
Il
nostro Niccolò.
Ovunque
sta’ ‘l pericolo
In
terra, in aria, o in mare,
Ognun
che ‘l sa pregare
In
salvo può condur,
Oh
quanti naviganti,
Quante
partorienti,
Da
grandine cadenti
Quanti
salvati fur!
Con
giubilo rammento
Quel
vago giovanetto,
Ch’era
tra lacci stretto
In
cruda schiavitù.
Il
giovane piangea,
e
‘l Turco lo schernisce;
Ma
ratto gli sparisce,
e
nol rivede più,
è
Niccolò colui,
Che
per la chioma il prende,
e
in un momento il rende
Al
mesto genitor.
Son
di memoria degne
Anche
le tre donzelle.
Che
meste e poverelle
Si
pascon di dolor.
Ma
il Niccolò che in loro
Qualche
periglio vede
Di
notte le provvede
Di
quanto bisognò.
L’autor
del ricco dono
Il
padre curïoso
Volle
spiarne ascoso,
Lo
vide, e ‘l pubblicò.
La
Manna poi mirabile
Che
scatorisce in Bari
Dall’ossa
singolari
Del
nostro Protettor.
Non
è un portento assiduo
Che
per la meraviglia
Ci
fa inarcar le ciglia
E
ci consola il cuor?
Oh
Bari avventurato,
Che
‘l gran tesor possiedi
E
te i divoti vedi
A
folla frequentar.
Chi
reca gemme ed oro
In
grato e pio tributo,
E
chi novello ajuto
Concorre
ad implorar.
Deh
Niccolò, gradisci
D’ogni
fedele i voti,
E
me fra’ tuoi divoti
Ti
piaccia custodir.
Acciò
da te protetto
Sempre
m’ajuti Dio,
E
alfin clemente e pio
Mi
voglia il Cielo aprir
Aggiungo
ancora che l’iconografia dell’antico stendardo in seta della Congrega del
Carmine (con l’immagine di S. Nicola nel recto e con quella di S. Maria del
Carmelo con le anime purganti nel verso) – probabilmente lo stesso innalzato
dallo «stannardiere» Paolo Di Roscio nel pellegrinaggio del 1714 e oggi
conservato presso la cattedrale di S. Giuseppe – si trova alla base (ma in
forma rovesciata) del motivo su tela che il pittore Giulio Cesare de Litiis
(1734-1816) realizza per la chiesa del Carmine nell’olio dal titolo la Madonna
del Carmine con san Nicola e sant’Andrea.
(Fig.
6:
Stendardo)
Non
vi sono dubbi. In questo periodo viene strutturandosi l’impianto
antropologico-religioso della festa nicolaiana. A chiarire aspetti
significativi di questa vicenda giunge la deliberazione n.213/13 ottobre 1879
con cui il consiglio comunale di Vasto provvedeva alla cessione ad uso di culto
della chiesa rurale di S. Nicola della Meta di patronato laicale del Municipio
a favore del sacerdote sig. Giuseppe Miscione. Nella domanda ad hoc presentata
dal presbitero il 5 marzo 1875 si faceva presente che, nel 1874, veniva
riattivata per la prima volta la funzione religiosa della cappella dopo 38 anni
di totale sospensione della solennità (fig. 6). A partire dal 1836,
dunque, con l’istituzione di un camposanto provvisorio soppresso nel febbraio
1844 grazie all’apertura del nuovo cimitero in contrada Catello, la
festa di S. Nicola era stata cancellata. I 1750 cadaveri deposti nelle fosse
colà scavate impedivano nel luogo ogni ragionevole celebrazione festiva. Unica
clausola di rispetto prevista dalla cessione: impedire ai «pastorelli» il
pascolo nell’area ex-sepolcrale.
(Fig.
7:
Il restauro della chiesa di S. Nicola. Disegno di A. Celano)
(Fig.
8:
La deliberazione del 13 ottobre 1879)
Un’ultima
questione. Dopo il 1893 la festa viene nuovamente sospesa (non si conoscono le
ragioni) per essere riattivata nel 1903. Nel n. 14 di quell’anno, il
settimanale «Istonio» registra quanto segue: «Domenica 10 [maggio] dopo tanti
anni si è celebrata nella nostra città la festa di S. Nicola per voto di tutti
i pellegrini che non avevano potuto recarsi a Bari per le infezioni di vaiolo
manifestatesi nelle Puglie, con un concorso straordinario e considerevole di
popolazione ed anche di forestieri». Già. Una sorta di sollevazione popolare
richiedeva soprattutto la pratica processionale dalla cappella in città quale
meccanismo sostitutivo dello sbarco del Santo e del pellegrinaggio da Vasto a
Bari.
Che
cosa dire di più! Penso soprattutto ai pastorelli esclusi dal pascolo. A me
torna in mente il Pastorello Abruzzese dipinto da Filippo Palizzi che con la
sua zampogna poggiata sulla terra pare raccogliere l’aria degli abitanti
ipogei. Una suggestione. Nient’altro che una suggestione. Ma che, a poco di duecento anni dalla nascita dell’artista (16 giugno 1818-16 giugno 2018), riconduce
l’attenzione sul misterioso poggio di S. Nicola che, nelle sue profondità,
nasconde ancora le tracce dell’ottocentesco campo sepolcrale.
(Fig.
9: F. Palizzi, Pastorello abruzzese, cm 65 x 51)
(da Filippo Marino,
Vasto Gallery)
Pubblicato da Mercurio Saraceni